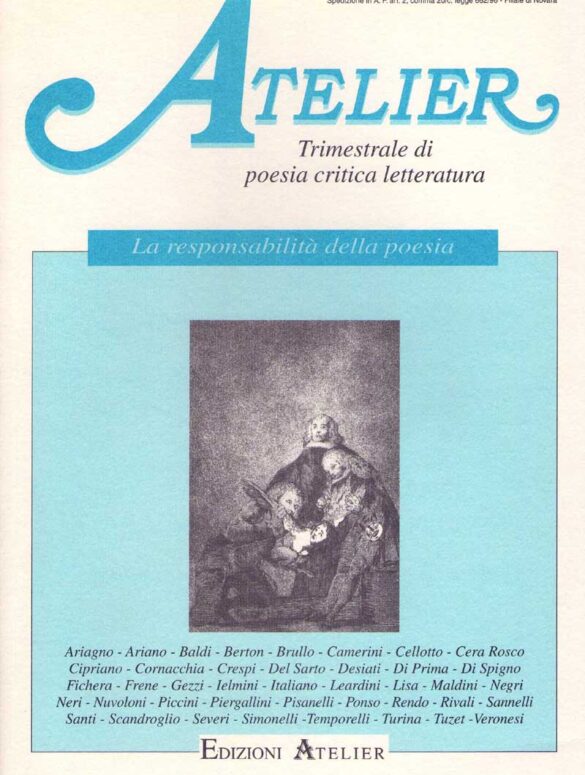Del magmatico universo in cui ci ritroviamo sbattuti come un fascinoso incubo ciò che maggiormente ci ammalia, dandoci una furiosa sensazione di libertà artistica, è l’altrettanto impetuoso tracimarci fin sotto i calzini di incalzanti e accerchianti forme linguistiche alquanto differenti tra loro. Siamo letteralmente assediati e picchiati senza scampo con le spalle al muro da parole che si presentano in tutta la loro paludosa loquacità, trascinandosi ormai inutilmente gli ultimi dispersi fardelli di senso. La parola evidentemente mai raggiunge il compito di “dire” che non suoni, di “far capire” altro che non l’ombra del significato cui è convenzionalmente aggiustata. La parola, qualsiasi essa sia, resta voracemente attaccata all’esperienza quale è quella sperimentata da ognuno per cui essa viene esasperata e sconfina dai suoi termini adeguandosi alla personale “lingua”. Ciò comporta un’inevitabile stasi di incomunicabilità o, per lo meno, la creazione di un’ipotetica zona franca in cui scambiarsi agevoli informazioni che non ci aiutano ad oltrepassarla e ad immergerci nella più profonda potenzialità della parola. La nostra società si basa su questo criterio di facile e banale comunicazione il più famelicamente fast, dimenticando che essa è, anche se non soprattutto, altro da sé, tesa a rimandare sempre e incessantemente alla sua dimensione sacrale. Nella fattispecie ci proponiamo di ricuperare questa sopita e primitiva prospettiva da cui è innaturale passar oltre pur tuttavia restando ben saldi nella nostra consapevolezza di essere parte fondante e, se possibile, creante di questo mondo e utilizzandone i codici che ci ha infuso nel sangue (da stolti è cercare fughe facili vie di scampo che ci riparino dalla lotta nel nostro solitario e quieto soliloquio).
Noi deriviamo la furia creativa e la cultura tutta – che lo si voglia o no – da una tradizione legata indissolubilmente al culto della Parola, che di questa e della sua esegesi ha fatto pietra d’angolo e patibolo. La parola prende un peso e una quota che sono irriducibili in facili termini che ne limitino il potere. Ogni atto artistico, ogni sforzo teso a straripare su un testo scritto non può prescindere dal responsabilizzarsi e farsi al contempo atto “morale” (mi si perdoni questo astioso termine visto comunque alla luce dell’ampio spettro delle sue possibilità). Proprio per la sua decisiva pregnanza essa segna, ferisce, crea varchi e poi squarci, deflagra in infernali spaccature e non possiamo scamparcela pudicamente senza prenderci la briga di darci una posizione un senso. La parola si storce sempre in ciò che non si riesce ad acciuffare, tende all’innominabile (rimanderei a tal punto al gustoso saggio di Viviani Il dicibile dell’indicibile, apparso su «Atelier» qualche mese fa), ma al medesimo modo è l’unico angusto luogo in cui gadameriamente si dà l’essere a noi conoscibile.
«La poesia stessa è religione […]; ho sempre concepito l’espressione artistica come atto sacrificale proprio nel senso mistico e religioso di atto propiziatorio di incursione nel mondo del mitico» scriveva giustamente Giovanni Testori in appendice alla raccolta poetica Nel Tuo sangue, in cui si scontrava con i termini della questione da noi analizzata. La parola e conseguentemente la sua forma più perfetta e misterica, che si infonde nell’atto poetico, in questa magica cifra in cui musica forma e contenuto si fondono su armonie che hanno del primigenio, è l’unico privilegiato tramite per farsi religione e preghiera e, a dispetto del suo compito stringente e limitante, non si riesce mai facilmente ad esaurirla, ad ammansirla in forme che potrebbero darci del banalmente sacro (e cos’è poi sacro se non la stessa stra-ordinaria ossessione del “dittar versi”?), perché la nostra benedizione ce la dobbiamo conquistare con la furia, l’ardore, la “fiamma d’amor viva”, il nostro continuo metterci in gioco, tracciare altre fenditure che ci portino persino a bestemmiare la parola, ad azzuffarci in mischia con essa, con la sua irritante carnale formalità. La parola ci sbatte contro la sua indelebile origine tellurica e femmina da cui non possiamo fuggire. È l’intuizione pura, la sola spinta emotiva inspiegabile e ineludibile che ci porta a vaneggiare versi, che nulla ha a che fare con affari della ratio e del consueto successivo labor limae. La sua natura poco porta di convenzionale, ma ci precipita nel fango di un preadamitico sabba. La parola ci chiama, assegna il suo proprio significato venendoci incontro e ci mostra quanto vana sia la nostra perpetua opera di imbrigliarla di renderla doma e innocua. Noi veniamo dalla stirpe di Isaia che nudo scagliava infuocati e poco civili versi per le città di tutto il Medio Oriente, perché così con il corpo e la parola voleva farsi servire il suo poco misericordioso Dio. Della terra avevano carne e nerbo le sue parole, dall’oltre nube ricevevano la grazia di essere comprese e profetiche.
Siamo ben lontani dalla disgrazia di Cassandra che per uno dei consueti scherzi dei Celesti ricevette il dono del vaticinio, benché inascoltato, tragicomico e inutile, incomunicabile per antonomasia. Noi deriviamo – che uno creda o meno – dalla radice del crocifisso, dell’impiccato sacrificato Figlio di Dio, appeso come un cane all’osso, che si è incarnato in parole e versi facendosi Logos, Verbo, e, quindi, comunicazione di quei vagiti che ancora leggiamo spolpati dalla sua carne. Questa Parola è stata beffeggiata e oltraggiata fino all’abominio della croce, bestialmente sputata e offesa, perché così potesse ri-suonare ri-sorgere a nuova forma e più perfetta a sanare e medicare il monco arto della lingua. Siamo della tradizione di una sacralità che ha fatto di scarna e inconcepibile violenza la sua cifra (e cannibale sacrificio di carne e sangue per l’eternità in qualità di arcana alleanza), che ha conosciuto la rappresentazione del reale mediata da un rapporto inquieto e distruttivo con questa sfiancante carnalità e che ha bisogno di braccare la sua clamorosa formula espressiva per risuonare dell’origine divina che la definisce.
Ripigliare peso e misura nell’incavo di questa possibilità del verso ci appartiene, ci ha segnato il volto e non ne possiamo fare a meno. Il sommar pensieri e metafore con il tono dimesso e sconsolato del secolo passato non può ripetersi. Il solipsistico ripiegamento nella propria disperata dimensione quotidiana non può germinare in frutti di giusto poetare. È nostra la voracità famelica di consumarci in questo mondo desolato in cui non ci sono più battaglie da combattere se non le nostre. È nostra la demiurgica e terapeutica ma devastante prepotenza del verso che a fatica e con astio aderisce agli argini del vivere civile. Abbiamo la libertà e la capacità nel braccio di trascendere il Tempo – questa è la terribile prospettiva dell’artista –, di sviluppare le nostre armonie, di far conformare le cadenze malsane al nostro passo. Proni e presi dalla condanna del versi-colare, dalla nostra improduttiva e denigrata ossessione che per ogni dove ci supera impedendoci il piano ragionare e l’ottusa apatia di pensiero, facciamo nerbo dell’agonia che ci è propria. Dopo il vano interrogarci sulla parola (recuperarne la scarna e cruda violenza oppure appoggiarla ad una barocca aggettivazione che la storpi ancor più? Fare della maniera che ne adombri i millenari significati riposti o mettere le carte in gioco smascherando il trucco?) e il vano ripeterci teorie e futili tentativi di spiegare ciò che sfugge come un pesce a qualsiasi quota conosciuta, riusciremo a darci nervo scoperto nel nostro ondeggiare versi e farci carne dei nostri brani?
È la donna ad emergere con avida potenza dai versetti evangelici, la sua tellurica sovranità, la gloria delle sensazioni dell’emotività e del materno istinto. Sono donne secondo Luca a sostenere economicamente il Cristo nella sua stravagante opera di redenzione per le piane di Palestina. Sono donne a seguirlo e ad esserne le più infervorate e incendiate sostenitrici fin sotto il legno della croce. Le uniche a non rassegnarsi e rifugiarsi come topi tra le sottane di chissà quale taverna al pari dei dodici, le uniche, dunque, a farsi peso del fardello della sofferenza, del terrore e del sangue scandaloso. In una tradizione quella giudaica, in cui, salvo sporadici squarci di poesia, la donna è bistrattata in qualità di mero ricettacolo del seme, mezzo solamente necessario alla replicazione della specie (la donna si ricordi è “fuori-legge”: basta scorgere tratti appena accennati del Levitico per farsi una ragione della sua impurità), sveglia quanto meno stupore la “rivoluzione” dei Vangeli. Se contiamo oltretutto il fatto che tali testi sono stati redatti da chi di quel mondo giudaico viveva giornalmente le fasi e ne condivideva una seppur inconscia misoginia (e che tra l’altro i quattro canonici sono di mano maschia), avremo forse il senso della portata grandiosa di questa intrusione. Non dimentichiamo, inoltre, la paradigmatica figura di una donna straordinariamente eletta come la Maddalena che, oltre ad essere a detta di tre Vangeli la prima a cui sia apparso il Cristo risorto (perché l’unica, l’amata, quella che poteva riconoscerne il corpo tutto per averlo lavato e dilavato dalle sue dita, checché ne possa malignare la patristica imbambolata e spersa alle prese con quest’evento grandioso), fu oggetto di una clamorosa venerazione da parte della gnosi. A lei è nominato addirittura un vangelo apocrifo, lei è la pressoché unica interlocutrice del Cristo nella Pistis Sophia, dotta summa filosofico-escatologica dello gnosticismo alessandrino. Di lei Filippo, autore di un’ulteriore apocrifo, parla come della “congiunta” del Cristo, la discepola segreta a cui erano riservati baci ben poco pudichi, vista la pratica che concerneva nell’insufflarsi a vicenda porzioni di fiato (ma benedetti, nel fiato era raggrumato lo spirito che avrebbe educato l’amata)…con malcelata gelosia da parte di Pietro e gli altri discepoli che schiamazzavano ad un trattamento quanto meno paritario… senza contare le leggende successive che vogliono la donna sposa accertata del Cristo e madre dei suoi pargoli!
La donna predomina (ed è l’istinto, l’irrazionalità, l’amorevole irragionevolezza) nella nuova evoluzione operata nel Cristo ed è parte integrante del suo progetto di salvezza e purificazione dei costumi. La donna è la terra che reclama i suoi morti, è la parola che cola dalle viscere mescolata alla razionalità degli evangelisti, dell’uomo che tutto deve vedere e aggiustare e misurare a spazio del suo braccio e definire gli orizzonti che lo accerchiano. La donna è la posa furiosa della penna che sbreccia e lacera il foglio imbrunendolo di segni all’apparenza oltreumani, l’uomo la volontà sicura di sguardare oltre di mai acchetarsi e di dar di legge. Solo l’uomo, che su questa terra non ha un ruolo se non la dispersione pluviale del seme, potrebbe dare, ossessionato dal centrare, costruire, innalzare, Inseminata alla donna questa novella parola può dar di messi e germinare. Primordiale potenza tellurica una legge di devastante fragore e ragionevolezza, capace di proporre a tutto una direzione. La parola si fa comunicazione ma mantiene inalterate e rimpolpate le sue qualità di ridestare sempre nuove vie di fuga e senso, capaci di ribaltare ogni volta il piano d’immagine. Siamo in bilico tra la forma ribaltata dall’iride e il suo opposto a testa sotto. La poesia ridisegna i suoi confini slarga gli argini a partire da questa comunione d’intesa: ispirazione a briglie sciolte e razionalità, spazio del dire, del darsi in sensi. L’intuizione del fare poetico (su cui forse è bene non interrogarsi, lasciare spazio al mistero come si fa con un presagio o con ciò che porta stupore), che chiede di spiegarsi e addensarsi in parole e versi per rendersi segno, comunicazione, sempre si ridesta e sgorga come la fenice o il corpo del Cristo in perpetuo sorgere.
È tempo di ritornare a una parola donna e terrena come lo è il nostro il corpo in grado di attingere alle remote sfere della materia, una parola che sia estasi, fuoriuscita dai propri varchi, allungata e straripante a cercare sempre nuove prospettive, nuove zone alte che propongano la visione più slargata, onnicomprensiva al modo del gabbiano o del rapace. Se la parola non è adeguata a tal punto, come una pellicola alla realtà, questa realtà deve essere in potere di trasmutare con il suo parlare (e ogni cosa che si nomina è possederla farla propria, adattarla a sé). Siamo, tuttavia, sempre memori che la parola intramata in un tessuto di detti e frasi non è che l’imperfetto riascolto del suono primordiale, la giaculatoria che nomina ciò che non può essere colto da nome come nella tradizione islamica, il canto di salvezza che parte dalle radici per sciogliersi al cielo al modo stesso dell’uomo eretto in pendolo tra il fango e vento.
Il poeta è, dunque, sentinella, colui che si fa portavoce ed ha lo sguardo lungo oltre il filo d’orizzonte, colui che deve ammonire e gridare senza posa, perché la sua parola è quella che trincera e graffia il fiato, ma che anche spalanca immense voragini di senso e lettura. E ,s’è vero che alcuna parola benché feroce può mutare il giro d’astri, ogni più impercettibile sommovimento di ciglia ha il potere di sbracciare in modo opposto la sorte.
Davide Brullo