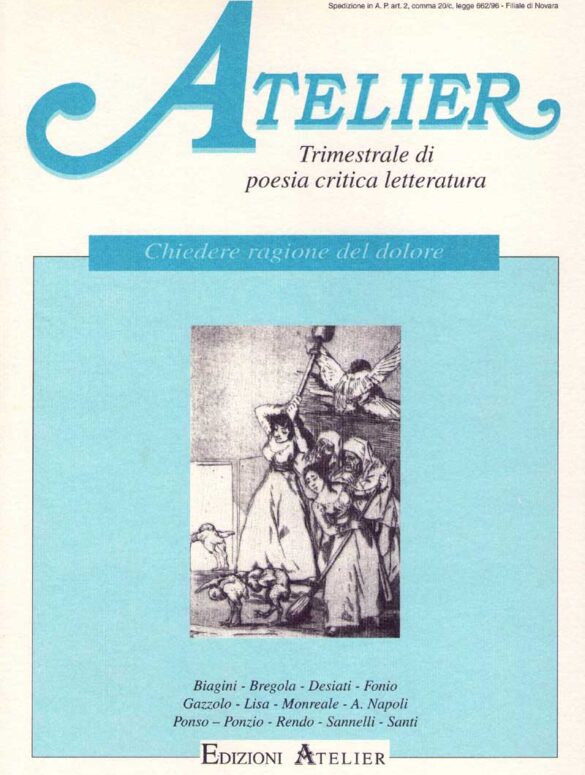Il complesso della presenza – ancora riflessioni su chiarezza e oscurità in poesia – di Andrea Ponso – da Atelier n. 23 – settembre 2001
Il problema sollevato dall’articolo di Umberto Fiori sul n. 20 di «Atelier», si presta, a mio avviso, a ulteriori considerazioni, perché, attorno a quel nucleo si aggirano questioni veramente fondamentali e fondanti, soprattutto per la nostra generazione che si trova a dover fare i conti con una sorta di ricapitolazione generale dei modi di fare arte, nel tentativo di proporre un superamento di dinamiche ormai prive della forza che le ha generate e resesi, quindi, se non di ostacolo, insufficienti per poter instaurare un rapporto di cosiddetto “ritorno al reale”. Infatti, ed è bene dirlo fin dal principio, è di questo che si parla ed è questo che è in gioco. Ma tale obiettivo, che probabilmente non avviene prima della poesia oppure dopo, ma “contemporaneamente”, è sempre stata fonte di infiniti equivoci, di forzature e di imponenti sovrapposizioni ideologiche. In modo non sistematico, allungando il respiro inseguendo le considerazioni molto stimolanti dello scritto di Fiori, cercherò di sfiorare alcuni nodi nevralgici del problema. Come intento vorrei arrivare alla stessa efficacia del lavoro da cui prendo le mosse, generandone altri, perché attorno a quest’isola non trovata dovremmo nuotare e veleggiare a lungo.
Occorre in primo luogo mettere in guardia il lettore da un equivoco ormai non più sostenibile: l’incanto poetico non è effetto del buio, ma, al contrario, dell’“estrema evidenza”. Un discorso che presupponga uno spazio interpretativo, diciamo così, una sorta di buio fra verso e supposto significato non fa altro che placare l’ansia di comprensione, creando un tipo di sala d’aspetto dove il fascino del “non ancora”, ma che dopo sarà, intrattiene il lettore fornendo la garanzia di un senso (e la garanzia del suo senso) e la sua sicurezza. La parte non detta, quindi, tiene in piedi l’intero apparato interpretativo, fa girare all’infinito l’elica e il motore della critica e nel suo vorticare silenzioso l’ombra apparentemente ostile disegna luoghi di senso, piccoli depositi a interesse, burocrati ligi pagati con il loro stesso lavoro, con il loro stesso luogo di fatica.
Allora, il problema dell’“oscurità programmatica” di tanta arte, è anche il “problema” al quale tanta critica si aggrappa e in generale è un vizio (pur sempre un vizio preziosissimo!) del modo di procedere del pensiero occidentale dalle speculazioni sulla Scrittura, alla mistica ebraica fino a noi. Ma, se in questi casi si può parlare di un’oscurità alta e altra, restringendo il campo e soffermandosi al livello dell’arte, dobbiamo ammettere che questa strategia è spesso deteriore. Questo procedimento rientra nelle dinamiche dell’arte moderna, in particolare dell’arte del Novecento (differenza, straniamento, ecc.), innescando un giro vizioso spesso infinito, nel quale anche la più trita semplicità è investita da una quota perturbante di ombra, che spesso altro non è che la testa di chi posa lo sguardo sia esso il critico o il poeta stesso. In questo movimento il circolo rimane chiuso in sé ed è formato da arte che genera altra arte, così che lo sguardo è chiuso al reale, nel suo orizzonte autoreferenziale. È questo forse il fatto più preoccupante, non nel suo movimento normale di rapporto con la tradizione, ma nel suo diventare movente quasi esclusivo e fondante: non l’arte che parla nell’arte, ma l’arte che “sembra” parlare d’altro costruendo steccati dal quale tutti noi cerchiamo di uscire. Così un ritorno ad una semplicità di immagini e di sentire, viene visto (ma attenzione, anche proposto dall’artista stesso, magari inconsciamente) come risposta ad un tipo di arte precedente.
D’altro canto, se questa strategia può gettare ombre e doppi fondi anche sulle immagini più semplici, provocando gli infiniti circoli dell’interpretazione, dall’altro inserisce il fenomeno arte – opera artistica, di per sé illeggibile e non collocabile, in un processo ben definito che giustifica ogni opera, qualsiasi tipo di esperimento.
Così, “ogni buio è in realtà una quota di speranza”, messa al sicuro e resa istituzionale per una rendita da riscuotere in futuro, paradossalmente una chiarezza con l’iniziale minuscola, che non faccia troppo male, che non faccia troppa luce, perché bruciare non permette una posizione comoda, non permette posture. Tanta arte è diventata questo “salviamoci”, questo circolo della tombola, dove l’unico brivido è la caduta del numero e la manciata di fave che può regalare una domenica pomeriggio.
Insomma, il gioco della modernità si svolge tutto nell’ambito dell’arte e non si rivolge più al reale perché, in tale dinamica, non ne ha più bisogno. L’idea stessa del creare – ma di un creare appunto in grado inferiore – è un continuo uso e riuso dei materiali di un cosiddetto testo infinito, degno di un’infinita ermeneutica. E l’idea di creazione, che aleggia in questo ambito, implica proprietà, storia, inizio e fine. L’uomo, e in particolare l’artista, non potendo più padroneggiare, nemmeno con la scienza (e su questo punto tornerò prima di concludere) la complessità dell’esistente, ama crearsi una storia “tanto per fare”, una rappresentazione che lo salvi dall’inspiegabile e dalla sua sparizione. Così, l’arte, da luogo dell’apertura e dello scandalo, da luogo dell’“infezione infinita”, da morbo e visuale senza parapetto diventa, invece, l’ansa comoda dove piangere ed elaborare il proprio lutto, dove esercitare le proprie piccole manie di grandezza e di proprietà che il fuori non lascia nemmeno più provare. L’artista legislatore, l’artista dalle grandi domande non ha più il coraggio di urlare e si accontenta dell’ospizio pulito e familiare del ben dire che la società gli concede, purché faccia qualcosa. «Ciò comporta un grande vantaggio per la coscienza ordinaria, questa è protetta dalla paura del nulla che nasce assieme al pensiero dell’essere; è invitata, e persino incitata, all’immaginario, che altro non è se non l’impiego degli aspetti parziali che – sostituiti, come sono, all’unicità, all’autorità dell’essere presente – possono servire il desiderio che ricostruisce il reale in base alla propria fantasia, su una scena in cui l’io stesso si vuole rappresentazione e non presenza. La mimesi ha generato la finzione creativa, che soddisfa il desiderio e fa dimenticare la morte» così scrive Bonnefoy in un saggio su Giacometti raccolto recentemente (Lo sguardo per iscritto – saggi sull’arte del novecento, ed. Le Lettere). E appunto il lavoro di Giacometti ci mostra la difficoltà dell’uscita di un volto, di un barlume di sguardo e di presenza, l’opera d’arte come residuo vivente di questa ricerca: lo scavo senza fondo di quei lavori è forse una delle vie d’uscita che l’arte sta cercando, una fuga da se stessa, un sapersi sbagliata e un accettarsi, un guarire, e quello che tocca a noi, “un guarire dal guarire”.
Altro punto sollevato dall’articolo di Fiori riguarda il primato della musicalità. A mio avviso, ciò che oggi persiste nella poesia a giusto titolo e che da sempre le è stato costitutivo, non è tanto la ricerca di un linguaggio il più possibile pulito dalle scorie della lingua d’uso e per questo più vicino all’asemanticità della musica, ma una propensione all’“Ascolto”: ogni poesia nasce dal bisogno fisico-orale di “ascoltar-si” (solo ascoltando si dà forma e di questo modo troviamo traccia in tutte le più grandi e antiche tradizioni di pensiero) anche la più lontana da esiti simbolisti o neo-orfici. E questo certo non esclude l’impegno nel reale, lo sguardo alle cose. Ma ogni poeta deve fare i conti con la “Voce”, quel sostrato fisico e spirituale assieme, anche senza accezioni religiose, che si annulla nel momento in cui la parola si articola. Un esempio su tutti, probabilmente il più grande, è certo Dante nel viaggio paradisiaco, senza contare la metafisica della voce dei poeti a lui affini del Dolce stil novo. La cosiddetta fuga verso la musica, beninteso, quando non sia puro gioco estetizzante-anestetizzante, è in realtà un passo verso la riappropriazione del proprio corpo e del corpo pulsante del mondo, nonché della sua origine in atto. Che questo poi comporti un problema di traducibilità sociale è altra cosa, anzi, è proprio il crinale che dovrebbe essere abitato dal poeta, oggi più che mai rintanato nel buio antro delle sue “incomprensibili” elucubrazioni, che tanto facilmente lo proteggono dalla “definitiva luce illetterata”.
Del resto, che cosa ci sarebbe di più grande che portare il lettore a fare esperienza dell’indicibile, quando l’indicibile è la realtà stessa nel suo essere lì, nel suo accadere come la poesia stessa? «Il creato è. Noi siamo. Questa è la grammatica rudimentale dell’insondabile» ci ricorda Steiner nel suo Vere presenze, saggio che nella trattazione della tematica della “presenza” nell’arte, ci ricorda come il movimento musicale è quello che più avvicina a tale radicalità, a tale semplicità senza nome, e alla domanda che per lui è sottesa ad ogni opera: perché non non essere?
A mio avviso, l’unico atto civile che la poesia può ancora operare è quello più radicale di farci sentire il respiro di quella realtà invivibile, tremenda, che viene prima di ogni legislazione, prima di ogni contratto sociale, ma di cui, comunque, è un nostro diritto impossessarci. La poesia dovrebbe farci diventare ciò che siamo, lasciando parlare due solitudini, perché solo tra due solitudini ci può essere ascolto e non dialogo. Dovrebbe essere “contemporaneità”, risonanza fisica del reale nel corpo, e il testo l’ordine che questa vibrazione si dà e ci dà : per questo in poesia occorre “essere decisi” (si noti il verbo al passivo): proprio in ciò si misura l’uomo, come nel suo destino. E il suo destino “è solo suo”. Questo lo accomuna (fa comunità?) agli altri solo nella sua diversità. E non è questa, poesia che dice e che nella sua solitudine dice la solitudine di ognuno senza s-piegarla, facendo comunità, vale a dire una diversa leggibilità, di ogni persona? Del resto, spiegare e piegare sono parole spesso pericolosamente simili. L’atto al quale bisogna fare particolarmente attenzione in questo tempo di manipolazioni e virtualità (deteriori) incontrollate, è allora proprio quello che, con la pretesa di “chiarificare” (leggi: rendere usabile, usufruibile, l’irriducibilità della vita) impone un punto di vista, all’interno del quale spesso la chiarezza è direttamente proporzionale alla pericolosità e al danno per la stessa esistenza – e questo non solo in tanta, troppa letteratura di consumo, ma molto facilmente anche nella produzione alta, anche se con l’uso di tecniche più raffinate e subdole: basta pensare a certi titoli usciti recentemente anche per grosse collane editoriali o a certo “maledettismo formale” o a certo linguaggio dell’urlo. Il fatto è che molto spesso succede anche a buoni poeti e a buoni scrittori quello che capita in maniera del tutto inconsapevole ai tanti “facitori” di versi occasionali: la trappola sta nell’uso di un certo codice apparentemente libero e carico di sentimenti, sfoghi, risentimenti, che dà l’illusione di avere trovato la valvola di sfogo, mentre è il classico straccio imbevuto nel cloroformio che tappa la bocca.
Altro equivoco, al quale bisogna prestare particolare attenzione, è quello relativo alla scienza e alla visione spesso insufficiente e distorta che il mondo delle arti ha verso questi campi della ricerca. In un mondo che va verso una specializzazione sempre più esasperata in tutti gli ambiti del sapere (basti pensare, anche in Italia, al progetto di riforma dell’istruzione universitaria) il potere ha certo interesse, per ovvi motivi, a tenere ben divise le diverse manifestazioni del pensiero. Così, si crede ancora, in questa nostra terra delle lettere, che il modello scientifico sia quello che cerca leggi e prepara modelli assoluti e sempre applicabili, per spiegare una volta per tutte come funziona questo enorme giocattolo. Il mondo, quindi, sarebbe diventato prosaico, spiegabile, misurabile, prevedibile, e così avrebbe perso l’incanto e il mistero che la ricerca scientifica ha rubato e che la poesia dovrebbe per lo meno cercare di inscenare o ancora più propriamente di rappresentare a scopo di intrattenimento, decidendo quanta quota di verità mostrare, quanta invece tenere nell’ombra. Le cose non stanno così. Se solo si pensa alle ultime acquisizioni dell’astrofisica e della fisica delle particelle, non si può certo sostenere questa tesi, anzi è piuttosto vero il contrario e cioè che il pensiero scientifico si è per così dire scrollato di dosso molti pregiudizi, togliendosi molti più occhiali di quelli che i letterati e gli umanisti continuano ostinatamente a portare. Così, ha saputo, in ragione del suo slancio più alto, prendere il posto che una volta era del poeta e dell’uomo d’arte, cercando di rispondere alle grandi domande. Anche per questo, l’arte è molte volte diventata un parassita che si autonutre delle sue rovine, che si addormenta con le sue musiche inutili (mentre non è inutile scoprire l’urlo della materia, l’ultima voce che una stella emette prima di collassare) che si crogiola nella elaborazione infinita del lutto: un insetto che gira rimanendo nello stesso punto, fino a scavarsi la fossa.
Certa arte purtroppo, malgrado l’evidenza, continua a mantenere il mondo in una visione che ormai è stata superata proprio da chi aveva un tempo contribuito a crearla, e la creazione artistica rimane in ritardo, chiusa prematuramente e volontariamente nella sua bara d’avorio (non più, ahimè!, altezza di sguardo e di orizzonte della torre d’avorio) preclusa alla realtà, appagata della “sua realtà”, ma oscuramente consapevole di essere in un vicolo cieco.
Occorre allora alzare lo sguardo, tornare al reale, certo. Indispensabile. Ma a quale reale? A quello delle curve di probabilità e dei tracciati delle particelle subatomiche? A quello visibile da un “orizzonte degli eventi”? o a quello della “presenza”, al suo “essere” lì, alla sua inspiegabilità nei limiti da sempre troppo ristretti del nostro linguaggio?
Occorre rimanere in queste domande, a mio avviso, per poter uscire dall’impasse che stiamo vivendo, e questo tocca principalmente a noi, della generazione più giovane, più disperati e per questo più liberi, liberi anche di capire e sapere che Heisenberg e Dante si sono posti le stesse domande sui limiti del linguaggio, ma sempre tenendo sotto agli occhi quel “bollore di prepotenze che è la realtà” e, come avrebbe detto Pasolini, il suo «mistero».
Andrea Ponso
E io non devo risolverla, perché non è un enigma:
ma conoscerla – cioè toccarla, vederla e sentirla –
perché è un mistero…
(Affabulazione, Pier Paolo Pasolini)