ISSARE LE VELE VERSO L’ETÀ DELL’ORO:
LA SPECIE STORTA DI GIORGIOMARIA CORNELIO E GIUDITTA CHIARALUCE
«Via… usciamo dal centro della sete.
I Ministri hanno già toccato lo strapiombo impresso nelle cose.
Quindi: partiamo.
E quanto lontano. Quanto lontano dovremo andare.
Laggiù, allo scoglio del globo,
all’Isola del Fosco Granaio»
Con questo proclama comincia la «strana partenza» verso l’Isola del Fosco Granaio dove svernano gli Spiriti Vecchi. Esistono vascelli che non solcano i mari, ma le acque dei secoli e delle realtà, onde cosi primigenie e ineffabili da avere la parvenza del cristallo, come quelle che si stagliano davanti al trono della divinità nell’Apocalisse giovannea. Sono le navi dei folli e degli sbilenchi, di tutti coloro che escono dalla regola, «i nati di contro» di cui sono portavoci i versi di Giorgiomaria Cornelio, le rupestri epifanie di Giuditta Chiaraluce, le prefazioni di Elena Frontaloni e Matteo Trevisani, le foto di Chiara Bruschini. Imbarcati su «un’arca fatta di micelio», nave organica che miscela i generi e ibrida le intelligenze, in viaggio alla ricerca «dell’epoca prima del nome proprio», per poter approdare in quelle terre iperboree di là da ogni oceano, dove «dopo mezzanotte/ albeggia mezzanotte». Isole leggendarie dei miti che risorgono rinnovate appena dietro l’orizzonte, dove nelle cosmologie antiche dimorano le presenze di soglia degli spiriti daemonici e dei veggenti, degli eroi e degli antenati, dove gli dèi siderei traghettati sulle sfere celesti si svestono delle loro pelli astrali e si apprestano alle navigazioni infere; dove gli antichi re taumaturghi dimorano in un sonno senza sogni in attesa di rinascere al cadere di un nuovo diluvio.
Il libro edito da Tlon raccoglie i testi del rito teatrale collettivo celebrato nella festa poetica I Fumi della Fornace di Valle Cascia, organizzata dall’associazione culturale Congerie in provincia di Macerata. Per la diceria popolare i fumi della vecchia fornace Smorliesi intossicavano i giovani rendendoli troppo eccentrici, creativi, queer e deviati. I fumi dell’orrore industriale sono stati però trasfigurati dai poeti marchigiani nelle esalazioni sulfuree che inebriano la Pizia delfica e la Sibilla cumana, nell’incenso bruciato nelle camere più sante dei templi dove il sacerdote incontra faccia a faccia il dio, nei fumi enteogeni che rivelano agli sciamani il corpo degli spiriti e li guidano nei viaggi dell’anima. Dal cadavere squartato del titano industriale è emersa una geografia sacra in un nuovo mito di fondazione, dove il tamburo e la voce corale conducono in processione iniziatica lungo il sentiero della memoria fino all’Isola del Fosco Granaio. Le fotografie del rito di Chiara Bruschini chiudono il libro, i cui cipressi accolgono i pellegrini con la stessa sacralità delle Isole dei Morti e dei Vivi dipinte da Arnold Böcklin. Tra le foto emergono le stature di Lucamatteo Rossi, Valentina Compagnucci, Valentina Lauducci, Pierluigi Scardino, Elena Martusciello, erti nelle posture e nelle auree di korai e kouroi elleno-etruschi. Una confluenza di teatranti eleusini la cui bellezza e sensibilità spinge a chiedersi da quale campo eliseo ed erebo siano giunti.
Scavare l’archeologia del possibile è il mantra di Cornelio, che ha trovato custoditi nel petto degli Spiriti Vecchi i «fossili di rivolta». Nelle immagini e nelle presenze antiche rinnovate dalla comunità profetica odierna c’è lo «spiegamento di possibilità che aureola le cose, restituendo evidenza a ciò che non riusciva più a mostrarne, scongiurando l’idea di estinzione, fenomeno che tormenta la nostra immaginazione come un miasma». I corpi negati si uniscono ai corpi degli estinti, come ricorda Claudio Kulesko, continuano a volare spettri tra le geografie, i miti e le sfere oniriche dei popoli umani, i corpi dei viventi plasmati sulla loro l’assenza. Spiriti che emergono nei disegni di Chiaraluce, come Lirriguardoso occhiovispo in copertina. Il muso rivolto al passato, le zampe al futuro, l’occhio rosso che apre allo sguardo animale. Chiaraluce traccia il tratto originario, la delicatezza dei bordi scheggiati esaltata dai pigmenti rosso, bianco e nero. Figure dai confini flebili e tremolanti, accennate al lume di una lampada cavernicola, in cui un qualunque sciamano ritroverebbe le impronte minerali con cui si invitano gli spiriti a dimorare nel disegno.
Gli storti in Cornelio adottano «la postura della valanga», partono perché «s’è consumata la spina dorsale, l’eterna epoca del Padre», in un richiamo gemellare, dopo più di un secolo, alla morte di Dio chiosata da Nietzsche e ribadita dallo sciamano yanomami Davi Kopenawa. Con lo stesso entusiasmo ineluttabile si salpa miscelando la fatalità di Zarathustra verso le Isole Beate unita alla compassionevole dignità dell’Almustafa di Gibran, epiteto di Maometto, imbarcato oltre la città orfica di Orfalese, nel mare del non-dove di Suhrawardi. Cornelio ispira da novello Galahad che inaugura una crociata di fanciulli, azzoppati e reietti diretti alla nuova Gerusalemme celeste, l’utopia che attende oltre il travaglio. «Ma voi che state nel crocevia col miasma, dateci un nuovo inventario, o guastate almeno la tara, il complemento di luogo». La catastrofe già presente nelle sue declinazioni ecologiche oscure, costringe i nuovi nati a ridosso del millennio ad adottare la manovra dello sbando. Sbandare significa seguire direttamente la visionarietà della poesia e attingere a ciò che sorge per esplorare nuove realtà, piuttosto che rifarsi a cosmologie prestabilite.
Chi nasce «dalla parte rotta del secolo» eredita un’autoiniziazione all’inconsistenza, dicono gli Spiriti Vecchi, per avere con il mondo «lo stesso contatto dello zoppo, che sa appoggiarsi anche all’aria». È il meccanismo buddhico più efficace per generare bodhisattva tathagata, i così-andati-così-venuti, «fatti come i giunchi, parte sciancate del ventre» di un titano Torcibudello che tutto divora, nella sua accezione maya «l’Iguana che inghiottì il sole al tempo della prima estinzione». Un dio primordiale che divora se stesso, e noi con Lui. Il titano è la forza che agisce dietro la scelleratezza umana come un’eggregora impazzita, «regola la calura del globo, e sceglie le dodici eclissi rivoltando il calendario», costringe a rivivere eventi eonici trascorsi dei precedenti duemila anni in una veste nuova, delirante e affamato si nutre prostrando i viandanti alla resa. Alcuni, li chiamiamo conservatori, omofobi e fondamentalisti, restano nel suo regno viscerale e non proseguono oltre, diventando profeti di sventura. Il negazionismo dilaga, «ciò che all’inizio era evasione, lo hanno nominato fondamento», critica tanto alle definizioni ossessive quanto ai totalitarismi soffocanti che ci attanagliano. Il mondo è ridotto a una nigredo miasmatica invivibile, ma il nirvana esplode a grappolo, «non siate così inclini a credere al dolore». La catastrofe rimesta, impegna a sé tutti i regni, quelli visibili e quelli sottili. «Ora c’è solo il mare, il mare attorno. Ci allaga un carico di devastazione», ma è una condizione spontanea, seppur da riscoprire. I naviganti nascono già naufraghi, «veniamo per passare».
Cornelio racconta tra le acque le Favole del Secondo Diluvio, di una Seconda Venuta. Il Primo Diluvio è il diluvio in illo tempore, da cui sorgeranno la Storia, la differenza e le specie. Per riunire il reale all’età aurea prima del cataclisma, gli antichi stilavano liste regali dei re-veggenti e dei loro saggi consiglieri, elenchi genealogici che poi sfoceranno nelle nomenclature teo-ontologiche della filosofia occidentale, formule magiche per ricreare il cosmo nell’inventario delle esistenze, dice Cornelio. Le parole si avvicinano alla ciclicità dell’uroboro, il quale divora se stesso in memoria delle acque e dei tempi prima dei tempi dove i cicli possono compiersi senza dirsi. Ma il diluvio è un diluvio mancato, nota Elena Frontaloni nella prefazione, dove «la serie nascita/distruzione rinascita/continuazione è sostituita dalla voluta e cosciente metamorfosi di solidali uomini, cose, luoghi, parole». Qualcosa, qualcuno rimane. Il diluvio non si realizza mai del tutto. L’eccedenza di Filemone e Bauci, Utnapishtim e sua moglie, la famiglia di Noé, tutti sopravvissuti ai rispettivi diluvi, unita a Tom Bombadil e Baccador, ricordano che c’è stato un tempo in cui il mondo attuale non era, e quindi la minaccia della sua distruzione è superabile. Le favole di Cornelio e Chiaraluce raccontano che l’estinzione non è una fine definitiva ma il preludio a un nuovo incanto. La rivelazione apocalittica deve mancare a se stessa, esangue già prima di scatenarsi. Cielo e terra, corpi e spiriti si riuniscono per sempre nella nuova era. Questo lascito, ci dice Cornelio, deve essere il pozzo da cui attingere la forza per guardare oltre l’oppressione attuale. Da qui l’epitaffio in calce alle Fondamenta di Sodoma, «Agli oppressori/ più ancora che agli oppressi,/ perché di loro non sarà la vittoria». I fascismi, le ortodossie religiose e i nazionalismi si pongono come fenomeni limitati nel tempo per via della loro stessa limitazione prospettica; distorti, disperati, e quindi destinati a morire.
L’oppressione si combatte attingendo alle stesse radici degli oppressori, ma trasfigurandone le immagini e lo zelo settario. Invece di farsi possedere dall’ecoansia e dal paternalismo di governi e chiese malate, bisogna per Cornelio trasformare le antiche cosmologie e dogmi «per non respingere tutto quanto è dannato, comprese le aberrazioni, le “fondamenta” e gli attrezzi che hanno fatto parte della causa dell’oppressione, e che ora siamo chiamati a rovesciare». Nella seconda postilla in chiusura Sul Fare Salvo, Cornelio si rivolge a tre figure cristiane come esempi di risanamento dell’aberrazione. Dell’arcivescovo James Ussher, che indicò la data di creazione del mondo nel 4004 a.C., sottolinea l’insensatezza del dato ma riconosce la vertigine di un metodo ispiratore di nuovo fervore. Da Origene, l’Apocatastasi che dichiara l’inevitabilità della salvezza finale, in cui «Dio sarà tutto in tutti», Cornelio ricava sia la certezza della nostra vittoria, sia una performance della redenzione che, riprendendo le parole di Walter Benjamin, si compie in modo affine alla favola, perché considera il crollo di un senso di realtà come liberazione da un incantesimo. Infine Marco Polo identifica l’inferno qui sulla terra e invita a trovare in esso ciò che non è inferno e lasciarlo perdurare facendogli spazio, «un trasalire che non distrugge la dannazione, ma genera un piccolo intervallo fra la cosa e se stessa». L’azione poetica diventa così «la riconoscenza a questo tremore. E farlo durare, e dargli spazio». La creazione di uno spazio intermedio che Cornelio riprende nello Zwischenraum dell’atlante Mnemosyne di Aby Warburg, una distanza consapevole tra sé e il mondo esterno, la metessi oscillante dei tathagata, dei sufi e degli stolti in Cristo, dei visionari o anche dei maestri zen ritratti non a caso con fattezze aberranti.
LA RIVELAZIONE DELL’ANDROGINO
«Ecco, ora va’, scendi nel tale luogo, entra nel tale corpo», recita lo Zohar ripreso da Cornelio, riesumando la mistica ebraica sulla reincarnazione a cui possiamo accostare l’invito della Bhagavadgita «Proprio come un umano depone i vecchi vestiti per indossarne di nuovi, così anche colui che si incarna dismette i vecchi corpi per indossarne altri nuovi». Un invito che parla tanto al prossimo Messia venturo quanto alle incarnazioni dei nuovi nati, tra cui Cornelio e noi tutti, che hanno «disubbidito al compito di scendere, all’inno color argilla», ovvero coloro che non hanno bevuto platonicamente alla dimenticanza del fiume Lete prima di rientrare nella Chōra platonica, trasmigranti ancora memori delle nubi e dei campi rigogliosi di là della dimora terrena, perciò non del tutto condizionati al farsi scolpire in un verbo di argilla dalla deità demiurgica. L’auspicio del demiurgo qui però non sembra tanto il dio creatore biblico che soffia il vento vitale nella forma di terra, né la sua ignoranza gnostica, ritrovabile nel Torcibudello, ma il color d’argilla ci porta al demiurgo dell’Islam dell’astrologo persiano Ṭabarī e del samanide Bal’ami. Nella creazione islamica, l’angelo della morte di Allah scende sulla terra alla Mecca e raccoglie argille di diversi colori, nera, bianca, rossa, gialla, azzurra, la totalità delle fasi alchemiche, offrendole al dio. Con queste argille, Allah plasma Adamo; per quarant’anni lascia la forma a seccare, poi ordina all’anima di entrarvi. Adamo viene alla vita con uno starnuto in cui loda il dio. Ci viene detto che quando Adamo ed Eva mangiarono del frutto dell’Albero, la loro pelle originaria si staccò dal corpo ed espose quella di carne che abbiamo ancora adesso, ma dei frammenti rimasero attaccati, che sono le nostre unghie. La pelle originaria quindi è adamantina e calcarea, comprende tutti i pigmenti dell’esistenza. L’argilla però alla fine dei tempi ci porta al demiurgo egizio Khnum, vasaio divino che modella col fertile limo del Nilo sia l’uomo che il suo spirito umanimale ka, e soprattutto a Enki, compassionevole demiurgo sumero. Ci racconta Jacobsen, quando gli dèi si appellarono alla dea del letto del fiume Nammu, madre di Enki, per liberarli dalla fatica del lavoro, Enki ordinò a sua madre di far plasmare con l’argilla dell’Abisso che lo generò le figure umane che poi la dea avrebbe partorito. In seguito Enki e la dea Ninmah si sfidano. La dea genera umani manchevoli e informi, tra cui un essere senza organi genitali maschili né femminili, ma Enki trova a ciascuno un’esistenza e un compito. Se la Grande Dea primordiale è padrona delle forme, Enki è un demiurgo che non raddrizza, ma domicilia la presenza monca nel mondo preservandone la stortura, ed è per questo che può plasmare un essere amorfo colpito da tutte le malattie e i dolori della vecchiaia, che Ninmah non riesce a nutrire. A differenza del demiurgo biblico, Enki ha a cuore tutte le possibilità d’esistenza e di inesistenza umane. Risuona l’invocazione alla Madre Creatora di Cornelio, «insegnaci il framezzo. Gli impacchi di rovescio. Il finitamente incompiuto», a cucire e scucire in circoncisioni e menarca la natura androgina originaria, la più suprema cantata da Elémire Zolla, tanto dallo yab-yum tibetano quanto dai cherubini in abbraccio ieroerotico del Secondo Tempio ripresi da Raphael Patai.
Cornelio cita le Lamentazioni sopra la città di Ur «Per giorni antichi, giorni diversi, giorni futuri!», genere letterario tipicamente sumero che nasce a seguito della distruzione della città di Ur all’inizio del 2000 a.C. causata da bufere, siccità e invasioni, dopo che la città era stata il centro della sua regione per più di un secolo. Gli dèi hanno abbandonato la loro casa, il dio dei venti Enlil scatena la sua furia su Ur, le invasioni elamite sono inondazioni. Ma come nel caso della città di Nippur, la lamentazione può aprire alla salvezza quando un re sacro, Ishme-Dagan, offre dei sacrifici per invitare nuovamente gli dèi nei loro santuari.
Se siamo nel Kali Yuga, l’Età della Confusione e delle Parvenze, in esso è il Satya Yuga, l’Età della Perfetta Verità, del pienamente manifesto perché perfettamente rivelato, dove il veggente è faccia a faccia con la verità dell’immaginazione sacra. Il Leone Sri Yukteswar pone l’apice del Satya Yuga all’inizio/fine della sfera zodiacale tra i Pesci e l’Ariete, mentre quello del Kali Yuga si trova tra la Vergine e la Bilancia, a indicare che la massima espressione delle due ere si trova sullo stesso asse celeste, e dopotutto in questo interregno o innominabile attuale, come lo ha chiamato Calasso, la vacuità delle ere fa confluire assieme le Età dell’Ariete, dei Pesci, dell’Acquario e del Capricorno, per non dire potenzialmente tutti i tempi, portandoci così immaginalmente nella sezione aurea indicata da Sri Yukteswar. Ma proprio perché la piena rivelazione completerebbe il gioco della vita, e quindi il ciclo delle rinascite, e quindi l’intera azione karmica che sostiene tutte le sfere in cui tutte le possibili presenze dimorano, cesserebbero allora i rivestimenti e le immaginazioni dei corpi visionari. Come potrebbero le divinità esprimersi senza ciò? Come potrebbero immaginarsi? Ma ecco la risposta di Cornelio, «E Cristo non può riposare», ovvero anche il Messia non può affrancarsi dalla creazione alluvionata, e soprattutto deve svestirsi di se stesso. Le rivelazioni messianiche, che si tratti dell’Ultimo Imam dei duodecimani o del prossimo buddha Maitreya, hanno visto la fine dei tempi di sbieco, condizionate dalla vecchia immagine del tempo, e perciò hanno creduto che il compimento di tutto si sarebbe realizzato entro i parametri della visionarietà della loro epoca. Si credeva che il Messia sarebbe stato uno, ma ora sappiamo che può essere molti. Due e più Re formano pur sempre una regalità non-duale. Perciò Cornelio si apre al peso dell’essere anche qui, implorando piuttosto «Fissatemi in alto», come il serpente di Mosé, «non io ho scelto/ questo scalzo inciampo/ nel tempo» e di convenire che il più divino ha da implorare perché «pure all’erba succede di avere sete». Si chiede l’immolazione che trasforma nel sacrificio, «Bruciatemi». Nell’immolazione il Messia non salva perché nota uno scarto legato ad un atto creativo incompiuto assolutizzato in sé, in quanto impossibile da esprimere, «il mon/do che ho nel mio pensiero/ non posso crearlo, e se lo creo è/ con parole che passano». A Lui (e qui il riferimento al Torcibudello è volutamente ambiguo) viene in soccorso l’azione del poeta veggente, dato che lo stesso Messia «divora il libro coi nomi amari», ma non li libera dal giogo perché l’antica parola divina non ha effetto ora come prima. La rivelazione che entra tra i tempi va rinnovata.
Cornelio cita Novalis a più riprese, il quale appura che la Bibbia non è mai conclusa, che sia sempre possibile continuare a (ri)scriverla. Federico Campagna riprende lo stesso spirito, bisogna dotarsi della stessa veggenza dei profeti per tornare alla radice del linguaggio dei testi sacri. Dobbiamo riscrivere la Bibbia per adattarla al nuovo spirito del tempo, un monito che vale per ogni testo sacro, ma inoltre dobbiamo scrivere nuovi testi sacri direttamente legati a quest’epoca. L’invito si palesa già nel libro di Cornelio perché i capitoli delle Fondamenta di Sodoma e dei Nati di Contro hanno l’intenzione di riscrivere il Libro di Giobbe, seguendo la lingua di Guido Ceronetti ed Emilio Villa. Goethe lo dice bene nel Faust, poeti e veggenti saranno sempre generati dalla terra in ogni epoca, così come sempre sono stati generati. Hölderlin più di tutti ha incarnato la profetica visione che trascende l’eone cristiano perché mai ne è stata circoscritta. Egli riunisce Ercole, Dioniso e il Cristo nei Tre che sono Uno, superando e trasfigurando la trinità cristiana per espanderla oltre la propria età in cui mai è dimorato, tornando al motivo sciamanico dei tre fratelli, che riunisce contemporaneramente l’eroe guerriero solare, lo sciamano androgino universale e l’illuminato sempiterno. Se per Hölderlin la venuta del Cristo aveva segnato la fine del giorno degli dèi, però mai scomparsi, in Cornelio parliamo noi tutti poeti veggenti nati nel campo cristiano, «Noi chiudiamo la storia/della colpa». Colpa che ha voluto dettare l’essere-nel-mondo attraverso la Caduta; colpa di una natura queer incategorizzabile ostracizzata fin da quando, riprende Cornelio, nel XIII secolo la sodomia diventa peccato contro natura proprio in conseguenza all’affermarsi di una più incisiva categoria di Natura; ma anche colpa imposta da generazioni appartenenti a un vecchio Novecento dilaniato e putrefatto che sembra oggi non avere altro da offrire se non i propri rigurgiti fascistoidi. «C’era in noi un trasecolo indurito,/ un idolo di pietra, pazien/te, da sciogliere con schianto di salive», il monolite da sciogliere per ardere con gli dèi, ritornando al momento della creazione, dove gli Igigi sputano sull’argilla ancora fresca preparata dalla dea Nintu. Se dall’Albero della Conoscenza si esce dall’Eden, dall’Albero dell’Immortalità vi si rientra.
Dopo il travaglio tra le isole, nel Secondo Diluvio Cornelio inaugura la Rinnovella, «ruota e sciacqua,/ con nuovo/ diluvio universale/ “Perché ecco,/l’inverno è passato”». La riscrittura dei testi sacri e l’avvento di nuove rivelazioni ispirano un nuovo tomo millenario, «la bibbia bianca ha solchi invisibili. Pure il carbone la riverisce. Cavati un occhio e leggerai». L’invito odinico che ci affratella spinge a guardare il bianco nella mistica dei colori di Vasilij Kandinskij e Kazimir Malevič, una luminosità che sorge dalla trasparenza prima dell’Origine. La bibbia bianca si pone nella stessa scia dell’Apocalisse descritta da Pietro Citati, un libro allo stesso tempo bianco e rosso scarlatto. Sono volumi che manifestano i sette colori primigeni e che ho chiamato altrove libri eonici. Così come nel XX secolo Jung compose il Libro Rosso, nel nostro secolo noi miniamo il Libro Bianco. Coloro che possono scrivere il tomo sono «chi ha polvere nella bocca./Chi è nato sotto il tamburo./ Chi non serra il cerchio./Benandanti, sconclusi, dis/sepolti, male fatti. Siamo/ sempre stati qui: nel punto/ in cui le parole si ritirano», nel bianco che precede ogni parvenza. Si è creduto, non a torto, che la Storia fosse finita, ma in realtà la fine della Storia è l’incurvatura di un arco. La Storia la fanno i veggenti, ora più che prima, coloro che sanno, che vedono, che sentono, che portano alla comunità il ruggente fuoco divino, l’oro che si dissolve in polvere, la parola intuonata, la sensualità dei divini.
«E adesso che l’uomo malanna,
che a grandi ondate s’inceppa
il meccanismo
scopritore di terre, resta da
inventare un continente
per quelli che furono estinti»
Alessandro Mazzi
* * *
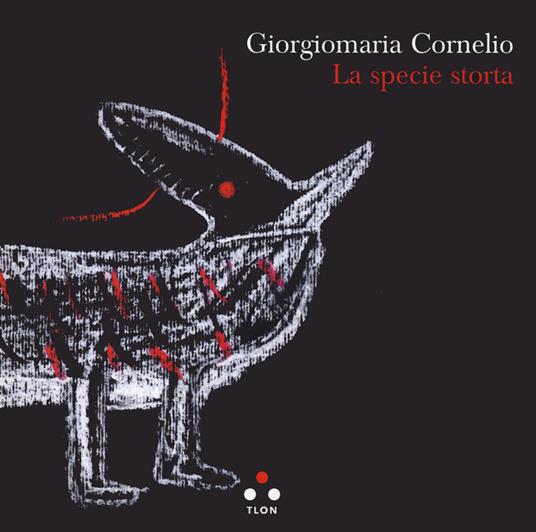
* * *
Giorgiomaria Cornelio (1997) ha fondato insieme a Lucamatteo Rossi l’atlante Navegasión, inaugurato con il film “Ogni roveto un dio che arde” durante la 52esima edizione della Mostra del Nuovo Cinema di Pesaro. La loro “Trilogia dei viandanti” (2016-2020) è stata presentata in festival e spazi espositivi internazionali. Cornelio è poeta, regista, curatore, redattore di «Nazione Indiana». Suoi interventi sono apparsi su «Le parole e le cose», «Doppiozero», «Il Tascabile», «Antinomie», «L’indiscreto». Ha vinto il Premio Opera Prima con la raccolta “La Promessa Focaia” (Anterem, 2019). Per Argolibri, ha curato “La radice dell’inchiostro – Dialoghi sulla poesia”. Per Luca Sossella Editore, ha pubblicato “La consegna delle braci”. Insieme a Giuditta Chiaraluce ha ideato il progetto di esoeditoria Edizioni Volatili. Dirige il festival “I fumi della fornace”. È laureato al Trinity College di Dublino, che gli ha conferito la Medaglia d’oro per gli studi.
Alessandro Mazzi (1990) è filosofo, editor e traduttore editoriale. Scrive per Kobo, L’Indiscreto, Singola, Siamomine e Rolling Stones. Ha recensito per Il Foglio. Esordisce con Il Crisomallo (Edizioni Volatili, 2022). Per l’Italian Institute for the Future ha curato Filosofie del Futuro (IIF, 2020). Suoi saggi sono apparsi in La Radice dell’Inchiostro (Argolibri, 2021), racconti in TINA. Storie della grande estinzione (Aguaplano, 2020) e su Axolotl. Ha tradotto La vendetta di Zarathustra (Agenzia X e Ampère Books, 2023) di Hakim Bey e Più brillante del sole (Not, 2021) di Kodwo Eshun. La sua raccolta inedita Bestiario Smeraldino è stata menzionata due volte al Premio Montano, sue poesie sono apparse su Atelier, Inverso e La Repubblica. Si occupa di filosofie del mondo e saperi indigeni, immaginazione sacra, antropologia e religioni, cosmologie non umane.
© Fotografia di Rossi Cornelio



