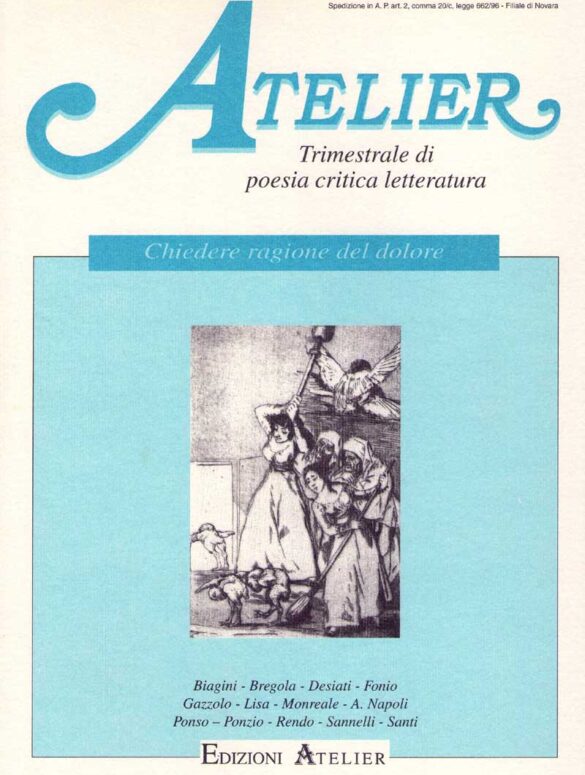Introduzione
L’idea di riproporre, in tempi di comunicazione globale, l’ipotesi di una linea regionale o locale per avvicinarsi alla poesia potrà irretire qualcuno, probabilmente quello stesso tipo di lettore perplesso ogni qual volta ritorna il concetto di tradizione poetica. Ma, riflettendo – senza nemmeno ricorrere più alla citazione di Dionisotti, considerate le reali e prepotenti mutazioni intercorse nella società e, dunque, nella comunità ideale rappresentata dagli scrittori e dagli intellettuali – si concorderà forse sul fatto che la poesia si radica su un terreno che può certo aprirsi ad uno sguardo complessivo, cosmico, epocale o cose del genere, ma senza perdere il contatto con gli umori, le zolle, i frammenti di un’esperienza personale anche geograficamente determinata. Si potrebbe arrivare persino a verificare come la poesia negli ultimi anni abbia, spontaneamente (ovvero senza una premeditata spinta ideologica) ingaggiato una sorta di battaglia di resistenza contro l’omologazione, l’imposizione di paradigmi universali che cancellano ogni identità alternativa, residuale. Il soggettivismo e la chiusura estrema nel privato (e magari anche nel dialetto) sono soltanto gli aspetti degenerati di un movimento istintivo di salvazione della poesia, del suo specifico apporto di sensatezza al mondo.
Tralasciando comunque tale aspetto, è sufficiente una disamina pratica dei percorsi di formazione di un poeta per comprendere l’importanza dei primi sodalizi, delle esperienze in rivista, insomma di quella “rete” di incontri, di informazioni captate come di sfuggita su frequenze poco determinabili, di contatti con istituzioni locali ecc. entro la quale si compie la formazione di un carattere poetico. C’è, insomma, una tradizione che implicitamente raggiunge lo scrittore non soltanto attraverso le proprie letture private, ma per mezzo delle suggestioni dei coetanei, del desiderio comune di partecipare all’esperienza della letteratura a partire dai suoi aspetti umani e sociali, cercando dunque referenti e, infine, respirando una sorta di aria comune, mettendosi a seguire, in modo personale e spontaneo, un percorso formativo che ricalca, per lunghi tratti in modo inconsapevole, una traccia fosforica che s’indovina sulla superficie delle vaste acque della letteratura. Chi intende invece la tradizione come un fatto lineare di semplice trasmissione ha un’idea elementare di storia, come di un gioco a staffetta. Ogni tradizione si gioca, infatti, su una contemporaneità assai stratificata (e ogni poeta elegge i propri contemporanei a partire da una eliotiana compresenza di tutti i tempi), su una concertazione polifonica che pare sconfinare nel caos (e ciascuno si aggrappi qui a piacere sulle etichette di moderno e post-moderno) e che certo apre il discorso della tradizione sulle diverse tradizioni che in essa si intrecciano. Direi di più, ogni tradizione è un atto rivoluzionario che rimette in discussione ogni forma di autorità del passato: tradere, ma anche tradire.
Giustificato una volta per tutte il ricorso a un’idea di tradizione o di linea, si potrà forse aggiungere che persino chi scrive queste pagine può testimoniare la stessa fenomenologia, provata soprattutto sul versante dell’esperienza critica. A un certo punto, infatti, l’intuizione dell’esistenza di una certa coesione fra diverse individualità poetiche (alcune delle quali verranno prese di seguito in esame) ha fatto sorgere, per via induttiva quindi, il senso di una tradizione, di un nodo, di una radice comune da verificare. L’etichetta di “poesia romana”, perciò, non è stata affatto ripresa da studi precedenti; anche qualora essa si riproponeva in qualche saggio o più facilmente in qualche passaggio involuto all’interno di un discorso più ampio, il nostro occhio automaticamente scorreva senza soffermarsi su di essa per giungere alla lettura dei singoli autori. Non mi pare nemmeno di avere mai trovato una definizione sufficientemente chiara di “linea romana”.
Ma forse è giusto riconoscere che una formula critica precisa risulterebbe, più che falsa, falsificante, nel senso che il riconoscimento di una piattaforma, per giunta poco stabile e in progressivo scioglimento, non può pretendere di esaurire il discorso sulle singole fisionomie poetiche. Trovare e sottolineare soprattutto gli elementi permeabili fra diversi scrittori non vuol dire risolvere la loro esperienza all’interno di quella cappa interpretativa: ognuno, installandosi su quel terreno incerto e mobile, andrà riconosciuto da subito come entità che si differenzia almeno nello stesso grado in cui partecipa alla tensione comune. In queste pagine si parlerà, quindi, di “poesia romana” non con l’intenzione di ordinare una specie di cassetto mentale del critico, ma con la precisa volontà di verificare, per via di scrittura, la sensazione dell’esistenza di un’origine comune e indifferenziata, magari remota, alle spalle di ciascun percorso poetico. Anche per questo, non forniremo in avvio alcuna definizione di tale “linea”, cercando semmai di formalizzare in conclusione le suggestioni raccolte dall’analisi, pur rapida e colpevolmente sbrigativa, di vari caratteri poetici.
Un’ultima, doverosa precisazione: senza troppe frequentazioni, al di là di quelle cercate con i coetanei e con pochissimi (due-tre) poeti appartenenti alle generazioni precedenti, il lavoro critico che vado compiendo da un po’ di anni si caratterizza a sua volta come un’acquisizione solitaria ed autonoma, che non pretende di sfuggire alla logica di un’implicita appartenenza a qualche esperienza poetica già etichettata (e che qualcun altro, dall’esterno, magari potrà indicarmi), ma che certo si sforza coscientemente di esaurire il proprio mandato prima che i rapporti si stabiliscano e subentri l’amicizia, la conoscenza personale, il debito intellettuale e umano. Insomma, leggere dall’esterno (e in questo caso specifico anche relativamente da lontano) può essere un vantaggio, ma è anche assai rischioso: le informazioni captate sono ancora più incerte e frammentarie e laddove si rivelano depurate dalla compromissione affettiva di chi riconosce un volto noto dietro ad esse, sono altresì decodificate, in modo talvolta violento, da un ascolto non in grado di intuire le inflessioni più intime, le risonanze originarie percepibili solo dall’interno. Leggere il Novecento dall’esterno è un atto drammatico, non certo indolore.
Beppe Salvia
Vorrei cominciare questa rassegna, però, non con un intervento critico ma con un omaggio a Beppe Salvia. C’è una poesia di Silvia Bre a lui dedicata che merita di essere letta per intero, non soltanto nel suo valore di commosso dono a un poeta prematuramente scomparso, ma perché esprime in poesia in modo compiuto quel senso di coralità che si va cercando all’interno della scuola romana:
Non è l’anniversario di un’assenza –
è che ti trovo qui nei miei pensieri
come un custode fermo sulla porta
che dà sul mondo e sugli ingressi scuri,
con l’aria di chi ascolta una parola.
Noi ti pensiamo.
Andartene fu un ordine severo
al quale continuiamo ad obbedire –
siamo rimasti qui, dove ogni tanto
si nomina il tuo nome,
dove hai lasciato a respirare i versi:
stiamo al tuo posto – eredi di una sedia –
tra le cose. Ancora non sappiamo
quale male fu tuo che non è nostro.
Altrettanto, e con toni consapevolmente ancor più prossimi a cadenze retoriche, anche per affinità di vedute poetiche, Damiani rende onore all’amico nel suo ultimo libro:
E tu, caro,
che sei una parte di me, che sei nel mio cuore
nella parte più interna,
Beppe Salvia,
caro fiore, reciso,
posi luminoso e illumini questo tempo
in questa camera buia
tra tanti cari amici che ti sono intorno
e ci teniamo per mano1
mentre Gabriella Sica ricorda in Sia dato credito all’invisibile la stessa figura con una prosa, nella quale ne rimarca la centralità generazionale e accenna a quel progetto poetico di chiarezza, di classicità, di sincerità che rappresentava la scommessa più profonda di Salvia e che costituisce altresì un nucleo comune certo fra diversi autori, i quali si trovarono a condividere, in particolare sulle riviste «Braci» e «Prato pagano», i periodi della formazione:
Nel 1987 usciva presso Rotundo Cuore, secondo libro postumo di Beppe Salvia, poeta già memorabile per un’intera generazione e tuttavia ancora poco conosciuto. Già nel 1985 intitolavamo Cuore una delle rubriche del nuovo «Prato pagano» in omaggio a Beppe, che del lavoro di quella rivista era stato uno dei protagonisti fin dalla sua fondazione, all’inizio degli anni ottanta. […]
Restituire un cuore al mondo, fare del cuore il metro etico ed estetico della vita è gesto ripetuto nella continuità della tradizione letteraria, da Saffo a Sant’Agostino. Con un evento del cuore, Petrarca e Dante hanno trasformato il mondo occidentale.
Tuttavia, pur nella continuità, uno stesso slancio si rinnova. E questo aveva fatto Beppe, rilanciando con nuova forza, nel deserto del tempo moderno, in un Novecento spiritualmente impoverito, il suo richiamo tenero e rigoroso al cuore. Cuore era anche l’idea cinese di cui parla Beppe, che comprende il concavo e il convesso, lo Yin e lo Yang: «il tao è il pensiero della civiltà senza fine»2.
Silvia Bre
Il titolo della raccolta di Silvia Bre edita recentemente da Einaudi3, Le barricate misteriose (credo che il libro sia però una ripresa pressoché completa del precedente e finora unico titolo poetico dell’autrice, I riposi4), promette qualcosa di combattivo, una pronuncia frontale e impegnata, benché si intuisca già nella connotazione data dall’aggettivo una sfumatura attenuante, mentre nell’idea di “barricata” è in qualche modo racchiusa la dimensione privata dello spazio poetico (lasciando intendere che la battaglia si compie non per mezzo di armi, ma con strumenti di fortuna). E infatti, leggendo il volume, ci si trova di fronte a una scrittura raccolta in una specie di stupore sospeso. Lo spazio che si apre innanzi alla barricata è «un campo di silenzio», non ci sono slanci combattivi, dal momento che mancano persino i nemici. La promessa del titolo si scioglie pertanto in un senso minimalistico di resistenza al divenire, al passaggio quotidiano dell’esistenza. Ci troviamo coinvolti, nostro malgrado, in un eroismo privato, persino squisitamente femminile in taluni accenti e pose. Già le sigle interne delle sezioni, infatti, smentiscono l’impennata del titolo generale – a partire dal più importante di essi, I riposi, che suona come un invito a «concedere un’apertura ai tempi morti, agli spazi inconsapevoli, alla consapevole incertezza, all’imperfezione», come ebbe a dire a suo tempo Giuliano Donati5.
I testi della raccolta sintetizzano in un elegante equilibrio due elementi fondamentali: un certo gusto formale che, per l’esattezza musicale di alcuni versi (soprattutto endecasillabi) e per le preziose inversioni sintattiche (come per esempio nell’attacco: «Ma quali più avventure schiuderanno») si può definire classicistico, e un andamento libero e leggero, a tratti apparentemente svagato (nelle spezzature di qualche verso volutamente inesatto all’interno di una sequenza quasi perfetta). Tale equilibrio conferisce alla scrittura un carattere moderno e tradizionale, piano e fruibile; a tratti, in certi appoggi del discorso alla seconda persona – quel “tu” che funge da interlocutore e insieme da proiezione per l’io – pare di risentire la lezione maestra di Montale. Anche l’uso delle rime si conforma ad una regola di estrema discrezione, così come tutti i contrappunti fonici interni al testo restano lievi, appena percepibili. Per esempio, nella poesia «Ascolta, un viale avevo…», la rima di chiusura dita : vita sembra persino liberare musicalmente il testo (in contrasto con il senso espresso di “chiusura”), anziché suggellarlo, dopo i più allusivi richiami interni fra rose : amorose : cose. In altre circostanze, invece, qualche rimbalzo di suono sembra svolgere una funzione di rilancio del componimento: «E dunque il mio partire non riposa – osa, s’alza», «d’un invito / non udito mai», «è già caduto / perduto rincorrendo». Ma per un esempio forse sufficientemente rappresentativo del sottile riverbero eufonico interno alla voce di questa poesia, si può citare per intero il testo di p. 85:
Chiamo, ed è qualcosa o l’universo
a farsi avanti sterminato – a stare
quieto, interrato, come se fosse
il mio grande inverso
da scavare piano, con il timore
che alzi una mano prodiga d’attesa
le dita luminose,
e dica: siamo –
la formula paurosa della vita.
Se alcune rime interne potrebbero dirsi di primo acchito casuali (sterminato : interrato), cominciano ad acquistare pregnanza a cospetto dell’analogo riscontro fra piano : mano. Evidente, invece, è la rima, nella sede esterna canonica, fra universo : inverso, così come la rima di chiusura, già rinvenuta altrove, fra dita : vita, in questo caso puntellata dall’assonanza intermedia con dica. Tanta ricchezza di richiami in un testo breve, conferisce una certa rilevanza anche all’altra ripresa spontanea di due verbi all’infinito stare : scavare. Ma, senza, insistere in altri possibili dettagli fino ad un’analisi viziosa, il vero, più profondo contrappunto affiora nella rilettura complessiva, che prende l’abbrivo con un chiamo isolato, quasi a congelare lo slancio dell’apertura, e si chiude (prima dell’endecasillabo che suggella il componimento “svelando” la formula) nell’altrettanto isolato e perentorio siamo. Ecco, in questo movimento musicale si esprime quel senso di stupore sospeso che contraddistingue la raccolta. Del resto, non mancano anche dichiarazioni esplicite a definire la resistenza privata dell’autrice: «So a cosa penso: al verso buone e chiaro / che cerco di comporre […] La mia conversazione con la vita / può solo somigliare alle parole / che tentano un momento di quietarla». In questa dimensione di conchiusa e delicata sensibilità, «Non è accaduto nulla di più vero / del passare del tempo / fino a che il giorno è diventato intero». E tocchiamo con ciò il limite della raccolta, quel restare, della voce, protetta dietro alla barricata, come se l’ardore del tempo che si consuma restasse attutito, come se l’autrice trovasse la propria condizione eletta nell’osservare la vita dietro «ai veli d’una finestra», incapace di corrispondere ad un «invito» (parola che mi sembra davvero cardinale) e restando entro la sfera del proprio, estenuante, ascolto: «Ci vorrebbe del tempo per spiegare / che allargando lo sguardo / si sparisce, e quanto è bene». In particolare, proprio col tema della sparizione, Silvia Bre dà sfogo a una fragile sentenziosità dickinsoniana, che fa leva su una ritualità semplice e domestica: «stringo il mio tempo in un cerchietto scuro / come lego i capelli la mattina», «a noi che del tempo eseguiamo / le parti modeste», «abitudini care / che mantengono il mondo». Non è un caso che venga ospitata al centro del libro una traduzione proprio da Emily Dickinson. La forza suggerita dal titolo della raccolta, quindi, è la stessa debolezza di un poetare per minime cesellature, per frammenti che naufragano nella certezza che «ferma è la vita», se non addirittura «inutile, ignota». Legati «al tempo / come a una carovana nel deserto», questi versi ci parlano, con una sobria e un po’ vacua eleganza (talvolta crepuscolare, persino nei temi), la muta rassegnazione del vivere.
Gabriella Sica
La tentazione di leggere le Poesie familiari di Gabriella Sica6 sulla scorta delle affermazioni rinvenibili in Sia dato credito all’invisibile, volume di “prose e saggi” edito quasi contemporaneamente7, è avallata dalla stessa autrice, che definisce quest’ultimo un “controcanto in prosa” del primo (così almeno si legge nel risvolto). E in effetti nella prosa introduttiva dichiara:
Ci sono inoltre, in queste pagine, gli umori dei miei versi, in gran parte inediti o sparsi su riviste, scritti in questo decennio. Il «sentire delicato», la gentilezza o la civiltà non sono parole astratte, ma invisibili idee guida del nostro vivere. E poi c’è la necessità della lode, laddove più forte cresce l’ingiuria: sia dato credito. Ci sono i temi a me più cari: la campagna e la natura come le ho conosciute nella mia infanzia, la scrittura come aratura, i bambini, con il loro essere fanciullino davvero saggio e giusto, che sono come i poeti; e poi il luogo del «familiare» come ultimo luogo comunitario, l’io che scompare e diventa invisibile più per un atto di carità o per obbedienza alla vita che per un bel verso8.
Siamo così introdotti con spudorata genuinità in quella sorta di scandalo del candore che è il clima dominante dei versi della Sica. Il suo dire cerca l’innocenza del fanciullino, si pone in dissidio con il proprio tempo («Non sarà il momento giusto per essere contro questo secolo, contro il Novecento?») ricambiandolo con la lode, tanto da rovesciare l’acrimonia di Sereni («Amo il mio tempo») e pretendere che la debolezza della poesia sia la vera forza conoscitiva della nostra epoca, di tutte le epoche tanto da scommettere che solo nella grazia risieda la verità, in aperto contrasto con ogni ideologia (con la psicanalisi e la sociologia imperanti nel nostro secolo), e che nello stile più anacronistico, ovvero nell’idea più tradizionale di classicità, si depositi il seme della sapienza. Con ciò si compie un atto di fede (del tutto analogo, benché su altro versante, rispetto a quello compiuto dal mitomodernismo) sulla coincidenza di bellezza e verità («lodare il bello che è anche il buono»), sul fatto insomma che la misura poetica si depositi su un fondo etico. L’unica religione possibile attualmente all’interno del consorzio umano sarebbe dunque quella delle lettere, capace di sublimare il sincretismo (si pensi all’inseguirsi euforico, sempre nella prosa introduttiva a Sia dato credito all’invisibile, dei nomi di Gesù, Budda, Confucio oppure alle numerose citazioni dai classici, dai vangeli, dai poeti moderni, dai filosofi, dagli artisti, dai mistici).
Non può, naturalmente, non sorgere il dubbio di una ingenuità abbracciata senza indugi in tali pronunciamenti, che potrebbero sembrare affermazioni tanto ardue da ritenersi personalissime – l’autrice invece sente di compiere anche «il ritratto di una generazione che è vissuta e si è formata ai margini dell’editoria e dei media»9, una generazione di poeti «un po’ padri e madri di se stessi»10, perché hanno incontrato i loro maestri non sul terreno aperto del confronto umano, ma nello spazio ovattato della lettura, nel dialogo sui libri prediletti: come se anche il Novecento dovesse essere interrogato con la distanza attribuita ai classici, fuori dai coinvolgimenti ideologici e dell’impegno militante. L’unico impegno possibile è, infatti, quello di volgere la poesia al «patrimonio spirituale ed etico proveniente dalla tradizione»11, dando credito, appunto, «all’invisibile, che è fondamento e fine della poesia. È l’invisibile che ci mostra in tutta la sua concretezza e viva evidenza il visibile, il reale vero»12: e tali valori invisibili sono appunto la gentilezza, la delicatezza, la discrezione ecc. racchiusi nel canone millenario della poesia. Da qui la ripresa, in particolare, del magistero oraziano (dell’Orazio così interpretato, naturalmente):
Misura, da modus, è la fonte generatrice della poesia oraziana, una misura non gelida o vincolata a canoni classicistici ma intimamente nutrita dalla virtus che non è istinto e non è ancora virtù cardinale ma è piuttosto consapevolezza, conoscenza. Dalla virtù proviene la gioia oraziana che è conquista della pace sull’irrequietezza, della saggezza sul delirio, della libertà sull’ambizione13.
Necessità e sincerità e immediatezza sono la fonte generatrice della poesia, della sua limpida armonia, del suo lucido ordo, del sonus legitimus14.
Il poeta graziano è tenuis, né eroico e né tragico, e tuttavia devoto a una religione dello stile e della vita, senza presunzione o arroganza. Ha buoni, cioè sinceri, pensieri con un buono, sincero stile15.
Si tratta di una visione complessiva della poesia più che semplice, semplicistica, che non è certo priva di coraggio nei propri slanci («la poesia è felicità: essa trae nutrimento da un passato di dolore ma trova il suo compimento in un presente di serenità»16), ma che certo si radica su un atto di fede, appunto, compiuto a priori, vietandosi in tal modo ogni attraversamento della poesia novecentesca. Mi pare soprattutto per questo insensato l’accostamento di tale poesia con un’ipotetica linea della chiarezza, antinovecentesca, che trova in Penna il proprio campione (restano semmai sensati i confronti con Saba, Batocchi, certo Caproni); tale linea si pone, all’opposto, al di là di una soglia discriminante: sa di non potersi dire innocente e offre per mezzo del proprio candore, sia pure senza la minima esibizione, l’elemento oscuro e irrisolto del male – quasi si trattasse di una lucidità febbrile, di una malattia che si specchia nella normalità, soltanto presunta, degli altri.
I versi della Sica, cercando una misura come forma di giustizia («Se non si è accecati da una febbrile immaginazione o da un’eccedenza psicologica, se la misura, che è anche giustizia e attenzione, regola le parole della poesia, allora si può tessere una trama feconda tra le cose, tra gli uomini e Dio»17), non sfuggono invece alla fastidiosa tautologia di parlare della bellezza con la bellezza, tautologia che è, a ben vedere, viatico prediletto del Kitsch. La sensazione, dunque, a cospetto delle sue poesie, è sì di partecipare a una festa del vedere, a un’euforia di luce che restituisce onore alla natura, alla campagna, ai rapporti familiari e quant’altre cose il nostro tempo disonora, ma trasformando tutto in una sequenza di figurine vacue, troppo candide e innocenti per essere credibili, per far nascere la grazia dall’interno del dolore e dell’assenza di fede. Non è forse un caso che, pur cercando di «pensare per millenni» (così come il finale del saggio La lingua della lode recitava nella versione resa pubblica nel volume La parola ritrovata18), la poesia si conformi agli spazi ben più ristretti del Vicolo del Bologna – per ricorrere il titolo di una raccolta precedente19 – una sorta di «paradiso che stava bene in cima a quel popolare vicolo di Trastevere lasciato miracolosamente intatto dal tempo», dove ritrovare le visioni naturalistiche dell’infanzia perduta in un’Italia ancora contadina e “pagana” (e basti qui citare i titoli delle sezioni per rendere l’idea del libro: Poesie per le oche, Per il mare, Vicolo del Bologna, Cantami l’antica strofa d’amore… – una sorta di personale Cantico dei Cantici – Cavalieri d’antichi tempi santi – in ottave -, Pensieri – dove emerge la vena epigrafica e aforismatica), oppure consegnandosi agli spazi ancor più circoscritti di quel Familiarum rerum liber che è il recente volume di Poesie familiari. Qui tra strofe e versi levigati ma non troppo (accenti in quinta, strutture alluse ma non rispettate fino in fondo soprattutto per quel che riguarda il giro delle rime, spesso ridotte a “rime visive” ecc.) e storie semplici raccontate con una pronuncia classica a partire dalla medietà espressiva (con qualche concessione a diminutivi, vezzeggiativi e in genere a parole che abbassano ulteriormente il registro con inflessioni a tratti sentimentali) e dalla chiarezza linguistica, la tenerezza e la gioia di sottrarre al tempo le figure amate si adagiano dolcemente fra le braccia di un pensiero fiabesco e disarmante, che sembra parlare non a noi, ma a quel noi perduto nella memoria ancora capace di credere o di stupirsi di ciò che ora ci appare invece banalmente poetico, con uno slancio di fede davvero puro e infantile che non ci appartiene più.
Claudio Damiani
La poesia di Claudio Damiani sembra muovere da ragioni e intraprendere modalità espressive del tutto analoghe a quelle testé riportate per Gabriella Sica. Potremmo dire, sintetizzando, di trovare in lui la stessa poetica, ma spinta ad un tale grado di oltranza da trasformarne i dati peculiari in una sottile forma di ossessione.
Ricorriamo a quanto sintetizzato da Umberto Fiori a proposito de La miniera20:
Diminutivi, vezzeggiativi, esclamativi, interiezioni, effusioni, idilli: Damiani “si permette” pressoché tutto quello che le regole non scritte di un galateo poetico ormai secolare proibiscono (o quanto meno sconsigliano); si può dire, anzi, che l’identità del suo lavoro – un’identità nettissima fin dagli esordi – abbia preso forma proprio da un sistematico, caparbio rovesciamento di quel galateo. Leggendolo si pensa ai crepuscolari (soprattutto Corazzini direi) poi magari a Penna, a Saba, a un certo Caproni, e ancor più a quel diffuso e variegato antinovecentismo che ha fatto da antifona al Novecento più accreditato; ma la trasgressione “dolce” di Damiani mi sembra assumere – in questa fine di secolo – caratteri ancor più estremi ed estremamente anacronistici. Di un tale anacronismo l’autore è tutt’altro che inconsapevole e si affretta anzi a suggerirne – in versi – un’interpretazione forte, dove la polemica è appena attenuata dal tono mansueto: «Che bello che questo tempo / è come tutti gli altri tempi, / che io scrivo poesie / come sempre sono state scritte». Siamo di fronte, insomma, a un’idea radicalmente antimoderna di poesia, nata dal rifiuto di ogni avanguardismo, di ogni “progresso” in arte, di ogni feticismo del Nuovo; non per caso La via a Fraturno (la raccolta che è un po’ il cuore di questo libro) elegge Orazio a proprio nume tutelare e a proprio scenario il paesaggio arcaico e appartato della Sabina21.
Abbiamo appena parlato di poetica, a proposito di quest’autore: ci sembra sensato, a patto di intenderla nel valore di riflessione a posteriori, non in qualità di progetto poetico pre-determinato, viziato da un’opzione ideologica. Anzi, l’atteggiamento altrettanto disinibito di Damiani nei confronti del canone suggerito dalla modernità, sembrerebbe nascere da una disarmante constatazione storica, come già avviene per la Sica, circa il riconoscimento di quello che la poesia ha sempre rappresentato, con le forme e il linguaggio elaborato dalla tradizione, all’interno della nostra civiltà, se non addirittura di ogni civiltà (e si potrebbe aprire qui una finestra sulle frequentazioni della cultura orientale che sia Damiani sia Sica a tratti esibiscono). Del tutto estraneo all’ansia (decadente e nevrotica) di rinnovamento che l’arte ha sofferto nel nostro tempo, il poeta sembra prendere atto serenamente di quello che la poesia è, nelle forme che ci vengono tramandate fin dai tempi della scuola, nell’idea di poesia più semplice e schietta (e dunque del tutto riconoscibile come tale) che tutti hanno.
Ora, a prescindere dal fatto che ormai anche la tradizione moderna fa parte della nostra storia e le nuove forme poetiche da essa elaborate sono ampiamente filtrate anche nella cultura popolare, benché a diversi livelli e con un noto pericolo di perdita di specificità, di scadimento in forme di poeticità diffusa e banale (che peraltro sono ancor più evidenti nei confronti di un’idea antimoderna e “tradizionale” della poesia) e a prescindere dal fatto che questa posizione sia, a partire esattamente dai propri presupposti anti-ideologici, una presa di posizione ideologica bella e buona, nient’affatto innocente, va dato merito a Damiani di riuscire a bruciare tutte queste resistenze interpretative, di riuscire a portare la maniera assunta ad un tale livello di ossessività da rovesciarlo in uno stato di naturalezza di secondo grado (e, infatti, andrebbe osservato come il passaggio dai versi – su tutte le forme la più tipica è forse quella dell’elegia in endecasillabi, che trascolora poi in uno schietto versoliberismo – alla prosa sia del tutto indolore: le parole si dispongono in verticale con la stessa noncuranza con cui si inseguono in orizzontale, proprio per il principio classico della disinvoltura conquistata con un esercizio dissimulato). Giustificata con il rifiuto degli psicologismi in cui la poesia sembra essersi impaniata, liberandola, quindi, dalla sofferta necessità di giustificarsi in quanto poesia (per chissà quali sensi di colpa), la voce di Damiani sembra poter tornare a concentrarsi sulle cose. Compiendo un atto di fede – che come tale nel suo scatto determinante non va giustificato – nell’idea di poesia apparentemente più anacronistica, i suoi versi dicono, godono di uno stupore persino troppo innocente, creano dentro la finzione lo spazio per una rappresentazione della realtà. Non c’è dubbio, infatti, che questa poesia sappia raccontare e descrivere con una freschezza e una radicale libertà ben difficilmente rinvenibile altrove. Per mostrarci il mondo, il poeta non ha più bisogno di metafore, di preziosi analogismi, di oscurità verbali che nascono da un desiderio di potenza del soggetto. A ogni forma di poetica che dia credito a tali strategie, egli contrappone un abbandono ai valori “oggettivi” della lingua, che è un patrimonio non plasmabile a capriccio: ecco perché, paradossalmente, l’atto di fede compiuto nei confronti della tradizione poetica (riconducibile anzitutto agli snodi rappresentati dalle esperienze magistrali di Orazio, di Petrarca e di Pascoli) si risolve in un atto di fede nel mondo, come se la poesia non dovesse essere inventata, ma fosse già lì, e compito dell’uomo fosse soltanto quello di riconoscerla.
Da qui la gioia della nominazione che si concretizza in strutture di coordinazione e nel ricorso al polisindeto, in sequenze interrotte da frequenti fioriture emotive – esclamazioni, domande, espressione di stupore –, come ha rilevato Galaverni. Da qui il senso animistico con cui il poeta si rivolge alle cose e, come un fanciullino, le interpella, come si trattasse di persone.
Eppure,
L’aura di innocenza, la gioia di un’epifania o d’una visione, la prospettiva che s’indovina nella memoria dietro ogni sguardo presente, non cancellano l’inquietudine del mancamento. La casa del poeta reca anch’essa i segni della storia: l’infanzia che pascolianamente rappresenta può essere recuperata solo a partire dalla sua perdita22.
Il ricorso a urticanti (per la sensibilità moderna) e iterati diminutivi, la pretesa di una candida immediatezza («Tu dici: perché scrivi a ruota libera / i versi, non ti sembra che dovresti / meditarli di più, farli più densi / di contenuti?… […] non sei tu tesoro / a dirmi queste cose, ma è una voce / dentro di me»), le inflessioni patetiche e svenevoli, conducono a una implicita estenuazione del poetico, che insieme a un’esuberanza percettiva creano uno stato di euforia, di ebbrezza – al di qua della quale, peraltro, tale poesia non può che essere respinta. Con ciò, si prenderà atto del fondo doppio che essa nasconde: come un senso di tristezza di fronte alla constatazione che la nostra fede nelle cose coincide con un atto di autentico nichilismo: «Che bello che questo tempo, come ogni tempo, finirà, / che bello che non siamo eterni, / che non siamo diversi / da nessun altro che è vissuto e che è morto, / che è entrato nella morte calmo / come su un sentiero che prima sembrava difficile, erto / e poi, invece, era piano»23. La profondità ambigua di tale bellezza risulta a questo punto evidente, e inquietante.
Ha probabilmente origine in questo intimo problema il senso di eroismo della poesia di Damiani, portato a galla con più veemenza nell’ultima raccolta, intitolata appunto Eroi (per incidens: pure l’interesse per la cultura orientale si potrebbe innestare sulla disciplina con cui il soggetto deve consegnarsi all’universo).
In tale raccolta, Damiani raggiunge sicuramente gli esiti più convincenti. Le sue prime opere, infatti, non potevano non sollevare il pericolo della costruzione e della chiusura in una personale arcadia – rischio che in effetti il poeta cercava di scongiurare sottraendo, a partire dalle poesie più recenti della Miniera, i suoi versi al loro habitat per costringerli a un confronto con la storia e piuttosto al mito. Malgrado questo tentativo, allora ancora involuto, il dettato restava infarcito di forzature manieristiche che andavano dalla citazione alle più discrete e raffinate inversioni sintattiche e, soprattutto, alla coraggiosa ma estremistica ripresa della lingua della tradizione (per gli arcaismi lessicali e grafici basti la citazione di un brano emblematico: «Il mio tesoro viene ogni mattina / al suo giardino e di cure lo copre / d’ogni genere e d’opre: qua una stipa / leva, là un sasso allontana, qui uno / stelo paziente districa, poi a lungo / tutto lo mira stupita e lo guata / ferma reclina sui piccoli fiori / ad arco, muta coi riccioli d’oro / che quasi toccan le punte dei petali…»; con il finale: «Questo è il giardino; se lo guardi è forte / il lume che ti fere gli occhi / e ti rivolti, ma subito apprendi / che tutto è vero, ogni cosa che vedi / è vera, e svolge la vita nel tempo / e è intera…»24). Il risultato era quello di creare una sorta di crepuscolarismo sereno, tenero e non lagnoso.
Ora, con la nuova raccolta, gettando anzitutto sui familiari il suo sguardo inquieto, animato da questa dolorosa felicità del vivere, Damiani dà voce a quell’eroismo quotidiano che regge l’umanità nel suo effimero passaggio terrestre: il tema della morte è assolutamente centrale, per quanto essa venga indagata e disarmata con il disincanto di un fanciullo, con la disillusione di chi non vuole, perché sa di non poter, opporre resistenza. E finalmente riesce a farlo riducendo al minimo la maniera, semplificando il linguaggio, insomma ripulendo il dettato da tutto quello che risuonava ancora come del tutto letterario. Ciò non significa che abbia rinunciato allo shock generativo che si fonda su quell’anacronismo, su quell’atto di fede nella poesia di cui si è ampiamente detto; semplicemente, ora si riconduce tutto a una dimensione ben più profonda. Il poeta raccoglie ormai quasi completamente tale choc nella pronuncia, limitandosi semmai a riproporre il proprio antagonismo alle involuzioni della modernità parlando di Ade, di patria, di eroi, insomma trovando idoli ad altro livello. Inoltre, i nuovi esiti della poesia di Damiani accolgono, sebbene con estrema discrezione, anche un leggero soffio metafisico: gli episodi di vita quotidiana lievitano, facendo propria una certa aura allusiva. Se prima l’autore vigilava per non cedere a momenti di riflessione che staccassero lo sguardo dalle cose, ora sembra invitare il lettore, alla fine del componimento, ad alzare gli occhi e a meditare, ascoltando ciò che il poeta gli ha suggerito surrettiziamente. C’è dunque un acquisto di profondità, e ciò risulta evidente anche nella prova di poesia visionaria compiuta nel capitolo L’isola natante e negli immediati dintorni di esso. Si tratta di una ripresa del tema (dantesco, non solo classico) del dialogo coi morti – tentativo peraltro maldestro in alcuni passaggi –, che può ricordare anche certe esperienze contemporanee come Il cimitero dei partigiani di Mussapi. Con un rapido trapasso onirico, il poeta sente la propria isola muoversi e, prima di imparare a congedarsi da essa e lasciarla al suo viaggio surreale, incontra e dialoga con le ombre dei defunti. Il primo gli si presenta e dice, con esiti forse involontariamente comici: «Salve, sono Leone Damiani» e così via.
Resta, profondo e intatto, il dubbio che la vera sfida poetica (che non è un atto di volontà dell’individuo ma una necessità intima della scrittura e, dunque, un nodo della nostra civiltà) sia quella di recuperare una possibilità di pronuncia semplice e potente attraversando il simbolismo (inteso come ripiegamento dell’arte su di sé per una presa di coscienza fondamentale), non restandone al di qua. La crisi di identità della poesia va risolta, non rimossa. Resta la scommessa di una poesia che, senza far violenza alla natura, anzi interpretandola, participi davvero alla creazione – sia opera responsabile dell’uomo, non soltanto stupore infantile.
Marco Merlin
Note
1 Claudio Damiani, Eroi, Roma, Fazi 2000, p. 70.
2 Gabriella Sica, Sia dato credito all’invisibile. Prose e saggi, Venezia, Marsilio 2000, p. 161.
3 Silvia Bre, Le barricate misteriose, Torino, Einaudi, 2001.
4 Silvia Bre, I riposi, Bari, Rotundo 1990.
5 Giuliano Donati, recensione a I riposi di Silvia Bre, «Poesia», IV, 41, giu. ’91, p. 61.
6 Gabriella Sica, Poesie familiari, Roma, Fazi, 2001.
7 Gabriella Sica, Sia dato credito all’invisibile, Venezia, Marsilio 2000. La sigla riecheggia il titolo di Seamus Heaney Sia dato credito alla poesia.
8 Ibidem, p. 18.
9 Ibidem, p. 17.
10 Ibidem, p. 70.
11 Ibidem, p. 177.
12 Ibidem, p. 20.
13 Ibidem, p. 27.
14 Ibidem, p. 28.
15 Ibidem, p. 29.
16 Ibidem, p. 26.
17 Ibidem.
18 La parola ritrovata. Ultime tendenze della poesia italiana, a c. di Maria Ida Gaeta e Gabriella Sica, Venezia, Marsilio 1995, p. 144.
19 Gabriella Sica, Vicolo del Bologna, Forte dei Marmi, Pegaso 1992.
20 Claudio Damiani, La miniera, Roma, Fazi 1997.
21 Umberto Fiori, rec. a La miniera, «Atelier», II, 7, sett. 1997, p. 65.
22 Paolo Febbraro, rec. a La casa, «Poesia», IX, 97, luglio/agosto 1996, p. 60.
23 Ibidem, p. 73.
24 Claudio Damiani, La miniera, op. cit., pp. 29-30.